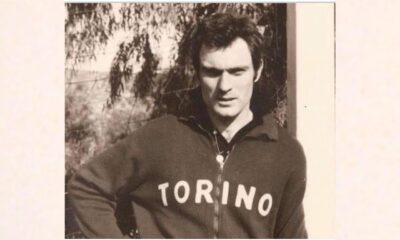GLIEROIDELCALCIO.COM (Riccardo Lorenzetti) – Il “Dottor Pedata”. Perché Fulvio Bernardini, dottore lo era veramente: in scienze economiche, che all’epoca doveva essere una materia ai limiti dell’esoterico. E in un mondo (quello del calcio) dove di laureati non se ne vedevano: che se avevi voglia di studiare, non c’era tempo di giocare a pallone, e quelli che giocavano a pallone non andavano oltre la corretta esecuzione della propria firma.
Prima il cognome poi il nome, naturalmente, come usava in caserma o negli atti di matrimonio.
Dottor Fulvio Bernardini. Uno dei primi, a memoria d’uomo, a rendere leggermente più scientifico il gioco del pallone… Cercando di nobilitare, con la sua classe, quel velo orgogliosamente plebeo che lo rendeva sport rude e non “adatto alle signorine” (definizione dell’epoca), dove vinceva lo scudetto chi menava di più (la Pro Vercelli) o chi intimidiva l’avversario a suon di revolverate (il Bologna del ’24).
Così bravo, e così sopra le nuvole, il Dottor Bernardini, da non aver nemmeno bisogno di chiarire il concetto di ruolo che aveva sul campo: un centromediano? Una specie di numero 10, o piuttosto un centrattacco alla Meazza?
“Era semplicemente una spanna sopra tutti, un atleta superiore per carisma, e per intelligenza di gioco. Che sarebbe diventato tranquillamente anche un grande portiere, se solo lo avesse voluto”.
Parole e musica di Vittorio Pozzo, che oltre ad allenare la Nazionale scriveva anche su “La Stampa” di un calcio che visto con gli occhi di adesso doveva assomigliare alle comiche di Ridolini, con tutta quella gente che correva velocemente, il pallone con le cuciture e i portieri con la coppola in testa.
Anche se poi, secondo Vittorio Pozzo, sarà proprio quella “diversità” a costituire il “discrimen” tra l’utile e l’inutile: tra ciò che serve per vincere il Mondiale o che, nello spicciativo calcio dell’epoca, potrebbe rivelarsi addirittura dannoso. E allora il Dottore, che è uno dei pochissimi ad essere conosciuto persino in Inghilterra, rimane a casa perché “troppo superiore” agli altri. E troppo bravo per non condizionare (in negativo) il gioco della squadra, che invece deve picchiare duro… Che se ci mettiamo in testa di giocare a pallone con Austriaci o Cecoslovacchi, non abbiamo scampo, nemmeno con il magno Bernardini in campo.
Anni di formidabili equivoci, alla ricerca dell’“italian way of life”, e di un codice genetico calcistico che si attagli alle nostre caratteristiche storiche e addirittura razziali (come pontifica Brera): l’esecrato “catenaccio e contropiede” da contrapporre al regale WM inventato dagli Inglesi e adottato dal resto del mondo.
Ma l’italiano è un popolo pratico: ha visto i giganteschi carrarmati americani durante il passaggio del Fronte, li ha confrontati con le scatolette di lamiera del nostro esercito, e ha capito perché si sia persa la guerra… Difficile convincerlo, quindi, che spostando in avanti, o all’indietro, una pedina si possa risolvere il problema.
Intanto, la polemica monta: con una veemenza tale da raggiungere toni da Guelfi e Ghibellini, che in fondo è quello che più stuzzica la nostra fantasia: l’Inter vince un paio di scudetti clamorosi, in faccia alla Juve di Boniperti e al Milan del Gre-No-Li, che sarebbero un ciccino più forti. E per arrivare a tanto, si dice, è bastato arretrare l’ala Armano sulla linea dei terzini, e liberare così il rude Blason al più congeniale ruolo di battitore libero.
Il “Dottor Pedata”, che è un esteta, arriccia il nasino ma intanto prende nota: gli tornerà utile alla Fiorentina, dove lo ha chiamato il Presidente Befani che è stufo di avere i tifosi che di notte gli tirano i sassi nelle finestre e non lo fanno dormire.
Bernardini va in Svizzera a dare un’occhiata al Mondiale: applaude convinto gli Ungheresi, che sono l’ultimo grido, ma si fa acquistare l’esterno brasiliano Julinho: giocatore talmente bravo da fissare i confini di un ruolo, e piazzare la sua classe come ipotetica colonna d’Ercole del giudizio: “un’ala può arrivare al massimo a Julinho. Non oltre”, sentenzia tutto ieratico il Dottor Pedata, che con le parole ci sa fare. E nessuno eccepisce, perché chi vince ha sempre ragione, e la Viola con Julinho, Montuori e Pecos Bill Virgili mette addirittura le mani sul suo primo, storico scudetto.
Oddio… A ben guardare c’è l’aletta Prini che, ad ogni partita, retrocede regolarmente a centrocampo, liberando a Beppone Chiappella la possibilità di poter giostrare da difensore aggiunto insieme al Capitano, Francesco Rosetta.
Sarebbe catenaccio bello e buono, ma Bernardini sa muovere la lingua, e sproloquia di tecnica e di tattica in modo così suadente da incantarti: basterebbe una qualsiasi seconda voce di una tv regionale, oggigiorno, per prenderti in castagna, ma siamo nel 1956, e nessuno ha titoli, competenze e autorevolezza per obiettare. “Questo Bernardini è un emerito furbacchione: ma, al contrario di molti suoi colleghi, predica male e razzola benissimo” chiosa Gianni Brera, che lo arruola immediatamente nella “chiesa” dei difensivisti, della quale è il Pontefice massimo.
Ma non è solo lo scudetto, per quanto colossale, il gran merito di quella piccola, provinciale Fiorentina. Piuttosto quello di mantenersi ai vertici del calcio italiano per molti anni, collezionando il record di ben quattro secondi posti consecutivi, una Coppa delle Coppe e la finale della neonata Coppa dei Campioni, dove al Real Madrid del grande Di Stefano occorre una specie di furto con scasso.
Rimarrà altri due anni in viola, con le grandi che gli fanno ponti d’oro: ma Fuffo rimane uomo da aziendina artigianale, non da catena di montaggio, e preferisce accasarsi alla Lazio e poi al Bologna.
Intanto sono arrivati i favolosi anni sessanta: il miracolo economico è ormai esploso e Milano, capitale morale d’Italia, è la locomotiva che trascina il nostro football ad una dimensione finalmente mondiale. Sarà il definitivo trionfo del gioco all’italiana, che troverà proprio alla “Scala del calcio” le sue migliori interpreti: il Milan di Nereo Rocco (che il catenaccio lo ha praticamente brevettato, ai tempi della Triestina e del Padova) e l’Inter del Mago Herrera: che, invece, avrebbe una gran voglia di vendere fumo, ma ha anche la miglior difesa dell’epoca, e su quella fonda le fortune della squadra.
Dall’altra parte della barricata, i cosiddetti “offensivisti”, con Mondino Fabbri che ha fatto meraviglie con il Mantova e adesso allena la Nazionale.
Il Dottor Pedata, dall’alto del suo prestigio, non vuole scottarsi al fuoco delle polemiche, e si piazza a metà strada: Il suo Bologna –dice- assomiglia alla famosa “terza via”, che va tanto di moda in quei tempi di cosiddetta “distensione”. È una solenne corbelleria, perché Janich e Tumburus sono di fatto libero e stopper, e Bulgarelli ha arretrato di almeno trenta metri il raggio d’azione: però i risultati arrivano e a Bologna tornano finalmente a vincere, trent’anni dopo lo squadrone di Schiavio e Andreolo che “tremare il mondo fa”.
Bernardini, che ha la definizione facile, trova lo slogan giusto: “così bene si gioca solo in paradiso”, che sarà il marchio di fabbrica di quella memorabile, diabolica stagione: uno scudetto quasi da guerra civile, tra la Gazzetta filo-interista e Stadio, che si stampa a Bologna… L’ombra del doping, il giallo delle provette scambiate, i punti tolti e poi restituiti e infine il presidente Dall’Ara che muore a due giorni dallo spareggio. Un feuilleton, più che un campionato, ma la stampa non cerca altro, e il calcio ha ormai soppiantato il ciclismo nel cuore degli italiani.
Sarà l’ennesimo capolavoro tattico del Dottor Pedata, che nello spareggio dell’Olimpico trasforma una debolezza in una forza: mancandogli il titolare Pascutti, trasforma l’ala destra Capra in un centrocampista aggiunto, guadagnando un uomo (e quindi la superiorità) nella zona del campo dove si corre di più. L’Inter ha la spia a rosso fisso e il Mago, checché se ne dica, non è un’aquila e si lascia incartare facile. Così, i gol di Fogli e Nielsen valgono uno storico scudetto: e il grande Fulvio Bernardini sarà l’unico, nella storia, a vincerlo due volte senza aver mai allenato né a Torino né a Milano.
Sono imprese che bastano, e avanzano, per elevarlo a padre nobile del calcio italiano. Fuffo viaggia sulla sessantina, ma qualche problema di salute lo convince ad accasarsi al clima mite di Genova, dove alla Sampdoria non par vero di affidargli una specie di ruolo da plenipotenziario.
Ma la Patria chiama, e arriva addirittura la panchina la Nazionale, che ha appena toppato i Mondiali in Germani. C’è urgente bisogno di una riverniciata: possibilmente una mano di arancione, come l’Olanda di Cruyff che ha sbalordito il mondo, e nessuno è più indicato del Dottor Pedata, che ha già dimostrato di saper togliere sangue dalle rape.
Nascerà l’Italia dei cosiddetti “piedi buoni”, perché Fuffo non perde il vizio delle definizioni geniali: una Nazionale in perenne sperimentazione che alternerà imprese importanti a diverse botte in testa, ma sarà anche (e soprattutto) la serra calda dove matura la generazione che il “nemico-amico” Bearzot condurrà al trionfo di Spagna ‘82.
Morirà, nel 1984, tra gli spasmi di una malattia rara e sconosciuta (la SLA) che all’epoca nessun medico è ancora riuscito ad identificare con esattezza.
La Roma gli intitolerà il Centro Sportivo di Trigoria